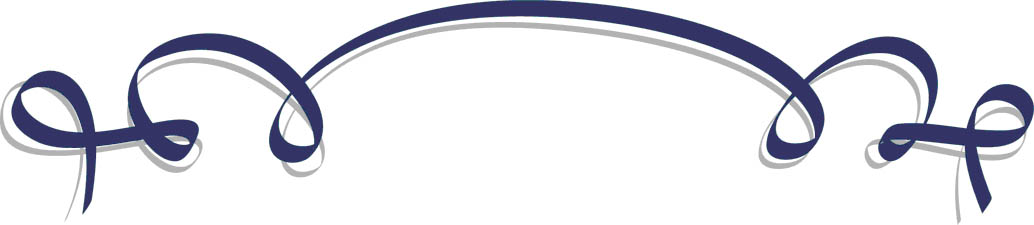
Ai tempi miei …

Appena nato ero già un contadino e da lì a pochi anni avrei fatto parte come
forza lavoro della famiglia. Sono nato nel 1914 ed ero primo di otto figli di
una modesta famiglia di contadini che lavoravano a mezzadria. La nostra famiglia
all’apparenza poteva sembrare povera, invece era tanto ricca di Dio e dello
Spirito Santo che ci ha aiutato e sorretto nel duro cammino della vita. Quando
ero bambino non sono stato tanto coccolato perché la situazione non presentava
tanto tempo a disposizione, in quanto i miei genitori erano sempre al lavoro nei
campi, anche se guadagnavano poco perché la maggior parte del raccolto,
precisamente i due terzi, andava al “padrone”, il conte Sgrilli di Rovetino,
proprietario delle nostre terre. Molte volte vedevo i miei genitori che si
grattavano la testa per la preoccupazione di come tirare avanti una famiglia
così numerosa, così mi sono abituato sin dalla tenera età ad accontentarmi del
poco, sia nell’affetto che nel pane quotidiano.
I miei genitori possedevano una
dozzina di pecore ed io sin da bambino andavo a pascolarle, trascurando anche lo
studio e la scuola. Arrivavo a scuola sempre di corsa e stanco, dopo chilometri
su una strada scomoda e fangosa. Dopo alcuni anni il lavoro del pascolo fu
affidato alle mie sorelle ed io dovetti andare a lavorare nei campi per aiutare
i miei genitori. Si lavorava tanto, ma con lo stomaco quasi sempre vuoto. Gli
uomini mangiavano di più per poter lavorare meglio e i bambini, invece, molte
volte, più di genitori, zii o nonni, mangiavano solo pane di granturco e
“profumo” di ceci, fagioli o cicerchia cotta, erano questi gli alimenti di ogni
giorno che i grandi della famiglia avevano il “lusso” di poter mangiare.
Per riempire la pancia un po’ di
più sognavo di diventare più grande e poter andare nei campi. Però ancora mi
dovevo accontentare del lavoro di pascolare le pecore. Ogni giorno, prima di
andare a scuola, conducevo quella dozzina di pecore che avevamo in pascoli sul
versante della collina. Le riportavo poi nell’ovile, che si trovava vicino alla
casa. Le pecore erano per noi molto importanti, infatti se ne ricavava latte,
lana, carne e formaggio. La produzione del formaggio veniva fatta in casa, in
una sorta di magazzino. Io aiutavo le donne di famiglia. Esse, in un recipiente
di rame, mescolavano a fuoco lento il latte e un po’ di caglio, una sostanza
contenuta nello stomaco dell’agnello, fino a creare una massa densa e
gelatinosa, che veniva poi messa in stampi per dare la tradizionale forma. Il
formaggio veniva poi fatto stagionare e si conservava nel magazzino. Come
sempre, i due terzi del formaggio andavano al “padrone” ed un terzo rimaneva a
noi.
Dalle pecore veniva poi presa la
lana. Dopo che gli uomini avevano tosato le pecore, la lana veniva poi lavorata
in un laboratorio vicino Comunanza. Anche i due terzi della lana andavano al
“padrone”!
Alla sera mi spettava poi
l’incombenza di far rientrare le galline nel pollaio, che era sopra l’ovile,
dopo che queste avevano razzolato e mangiucchiato per tutta l’aia per tutto il
giorno. Forse loro erano le uniche a godersi sempre un po’ di cibo!
La mattina poi raccoglievo le
uova fresche di cui una parte andavano al solito al padrone.
 Poi,
diventato più grande, sono andato a lavorare nei campi con gli uomini della
famiglia. Scoprii amaramente però che questo lavoro non era come lo sognavo da
piccolo, il lavoro era molto faticoso, si lavorava da mattina a sera e la pancia
era più vuota di prima. Per preparare i campi alla semina del periodo autunnale
si usava l’aratro. Esso era uno strumento molto pesante, per questo era trainato
da una coppia di buoi maremmani a cui attaccavamo il nostro juvë
(il giogo), dipinto a mano
con decorazioni. Mentre i buoi trainavano l’aratro, io dovevo tenerlo diritto
affinché arasse bene. Ricordo quando, dopo una frustata, i buoi si innervosirono
e cominciarono a correre, facendomi scappare di mano l’aratro. Che paura! Se
fossero entrati nella stalla l’avrebbero distrutta, se invece il vomero nella
corsa avesse colpito una gamba dell’animale l’avrebbe ferita, o peggio,
tagliata! Dopo come avremmo fatto a lavorare? Fortunatamente tutto andò bene, i
buoi si acquietarono poco dopo. Li compresi, capii che anche loro avevano fame e
come per noi era dura anche per loro, il cibo non c’era per nessuno, mentre il
lavoro era tanto e faticoso.(Il nonno mi mostra una foto in bianco e nero
mentre regge per le corna i suoi buoi che utilizzava per arare. Sono enormi!)
Poi,
diventato più grande, sono andato a lavorare nei campi con gli uomini della
famiglia. Scoprii amaramente però che questo lavoro non era come lo sognavo da
piccolo, il lavoro era molto faticoso, si lavorava da mattina a sera e la pancia
era più vuota di prima. Per preparare i campi alla semina del periodo autunnale
si usava l’aratro. Esso era uno strumento molto pesante, per questo era trainato
da una coppia di buoi maremmani a cui attaccavamo il nostro juvë
(il giogo), dipinto a mano
con decorazioni. Mentre i buoi trainavano l’aratro, io dovevo tenerlo diritto
affinché arasse bene. Ricordo quando, dopo una frustata, i buoi si innervosirono
e cominciarono a correre, facendomi scappare di mano l’aratro. Che paura! Se
fossero entrati nella stalla l’avrebbero distrutta, se invece il vomero nella
corsa avesse colpito una gamba dell’animale l’avrebbe ferita, o peggio,
tagliata! Dopo come avremmo fatto a lavorare? Fortunatamente tutto andò bene, i
buoi si acquietarono poco dopo. Li compresi, capii che anche loro avevano fame e
come per noi era dura anche per loro, il cibo non c’era per nessuno, mentre il
lavoro era tanto e faticoso.(Il nonno mi mostra una foto in bianco e nero
mentre regge per le corna i suoi buoi che utilizzava per arare. Sono enormi!)
-
Ma nonno,
cosa coltivavate?
Coltivavamo specialmente
granturco, fagioli, ceci, cicerchia, grano e canapa, avevamo inoltre un vigneto
e un po’ di ulivi. I legumi erano il nostro cibo quotidiano, insieme al pane di
granturco.
-
Cosa
ci facevate con la canapa?
Noi uomini raccoglievamo la
pianta di canapa; si faceva macerare in acqua, poi si toglieva il midollo dalla
pianta e si otteneva una poltiglia biancastra che si raschiava con un pettine
per ottenere dei fili. Le donne poi la filavano con la conocchia trasformandola
in un filo piuttosto robusto che veniva a sua volta aggomitolato ad un fuso. Il
fuso veniva poi disfatto con l’aspo, da cui si otteneva la matassa. La matassa
passava all’incannatoio che serviva a distribuire il filo a diversi cannelli che
a loro volta si sistemavano nella spola. Si passava infine al telaio a mano dove
si mettevano in movimento i licci attraverso un pedale e tessendo in ordito e
trama si otteneva il tessuto. Non tutti possedevano un telaio, per noi era un
po’ un privilegio perché la biancheria veniva prodotta in casa e serviva come
corredo alle giovani donne della famiglia.
Alla fine di giugno si cominciava
poi la mietitura, quando il grano era ormai maturo e le spighe avevano preso il
colore dell’oro. Il grano si tagliava a mano, per mezzo di una falce molto
lunga, sotto un sole cocente, la fatica era davvero disumana. Anche le donne
della famiglia ci aiutavano sia con il lavoro e sia con i loro stornelli che a
volte ci portavano ventate di freschezza. Uno stornello diceva: “Aria San
Pietro! Mandami lu vente perché lu sol m fa mal tant!”. ( Aria San Pietro!
Mandami il vento perché il sole mi fa male tanto!). Uno stornello quasi
propiziatorio affinché il santo ascoltasse questa richiesta in un momento di
tanta fatica e di calore. Una volta mietuto il grano si facevano dei fasci di
spighe legati insieme, i covoni, che noi chiamavamo “manòcchie”. Il grano veniva
trasportato con carri trainati da buoi nell’aia di casa, ove si svolgeva il
lavoro della trebbiatura. Quando ero piccolo, aiutavo gli altri componenti della
famiglia, mentre essi, tanto che il grano a quel tempo era poco, battevano i
semi su di una lastra di pietra o cemento, ricavandone la farina. In seguito
però il grano aumentò e si ebbe ben presto bisogno, per sbrigare il lavoro in
minor tempo, di una trebbiatrice. Ad annunciarci l’arrivo di quella macchina era
la sirena incorporata nel trattore che la trasportava. Tutti ci ammassavamo così
nell’aia ad aspettarla. Poi la si metteva in moto e ci affannavamo attorno ad
essa per mettere i covoni di spighe nel battitore che faceva un rumore
assordante e, sotto il sole martellante e la polvere che soffocava, dalle
bocchette si riempivano a mano i sacchi di grano che appena riempiti venivano
subito portati via per far posto ad altri sacchi vuoti. Da un’altra bocca
scendeva la paglia e con grossi rastrelli veniva ributtata in un punto scelto
per fare il mucchio. Quando l’ultimo covone scompariva tra i denti del
battitore, stanchi e sudati, tiravamo un sospiro di sollievo e la sirena della
trebbiatrice annunciava che finalmente questo lungo e faticoso lavoro era
concluso. Il sudore di questo lavoro si trasformava in raccolto e garanzia per
tutti. Il padrone era quello più contento se c’era stato un buon raccolto,
contento mandava il suo fattore a calcolare e portare via i sacchi di grano che
gli spettavano, ovviamente i due terzi del tutto.
-
Nonno, ma a cosa serviva l’aia?
L’aia era uno spazio di terra
battuta che si trovava davanti alla casa ed era il luogo in cui si svolgevano
tutte le lavorazioni dei prodotti raccolti in campagna. Oltre alla trebbiatura
vi si faceva anche la cosiddetta spannocchiatura, che ora ti racconterò … Però
dopo facciamo una pausa, ho la gola secca! ( il nonno sembra affaticato,
come se, mentre ricorda, stesse ancora lavorando, sembra che sia tornato a
quell’epoca, negli anni ’40…)
-
La
spannocchiatura? Ma che lavoro è?
La spannocchiatura consisteva nel
togliere dalla pannocchia di granturco le foglie secche, che servivano per
rifare ogni anno i materassi e i cuscini di noi poveri contadini. Dei prodotti
della campagna noi non buttavamo nulla! Questo lavoro era svolto, seduti a terra
nell’aia, da tutta la famiglia, donne, uomini, bambini e anziani, perché non era
un lavoro faticoso come la mietitura o la trebbiatura, infatti era sempre
accompagnato da canti e stornelli anche inventati al momento. Le pannocchie
venivano poi “sgranate” e i chicchi venivano portati alla molitura, da cui
ricavavamo la farina per farne un pane grezzo che mangiavamo abitualmente o, a
volte, polente.
Infine in autunno c’era la
vendemmia, un lavoro impegnativo e movimentato, ma non molto faticoso. Noi
contadini, armati di ceste e scale, ci addentravamo nel vigneto per raccogliere
i grappoli ed era così tutto una via vai: chi portava in testa i cesti stracolmi
di uva, chi li scaricava nei tini che erano sui carri, chi li portava nella
nostra aia e li vuotava in vasche di legno chiamate “pistarole”, dove l’uva
veniva pigiata con i piedi e lentamente usciva il mosto. Poi c’era chi torchiava
i raspi e chi metteva il mosto in grandi contenitori a doghe di legno. Dopo
qualche settimana, finita la fermentazione, si “svinava” e il primo vino
spumeggiante veniva riposto nelle botti.
Nonostante che questi lavori
erano duri e faticosi, dopo aver consumato la cena nell’aia, anche se si era
molto stanchi, io prendevo il mio organetto e facevo esplodere nell’aria le note
che invitavano al canto e al ballo contadino. Finivano così le nostre giornate
faticose … sempre con l’aiuto dello Spirito Santo.
- Nonno,
quando sei tornato dalla guerra hai continuato a fare il contadino?
Per un po’ ho continuato a fare
il contadino, ma non ero più scapolo, avevo famiglia.
Nel periodo dopo la guerra la
vita era dura e le difficoltà erano tante. Ci voleva pazienza, coraggio e fede.
Verso gli anni ’60 le cose cominciarono a cambiare, le prime TV iniziarono ad
entrare nelle famiglie e qualche automobile iniziò a circolare; io comunque
avevo sempre la mia bicicletta che mi portava dappertutto. Nella vallata del
Tronto iniziarono a sorgere le prime fabbriche che diedero lavoro a molte
persone. Come tanti altri lasciai la mezzadria per andare a vivere in paese e
lavorare in una fabbrica. Il salario era poco e il lavoro era piuttosto
pericoloso e senza sicurezze. Oltre ad essere un operaio come gli altri ero
anche addetto alla sorveglianza delle macchine. Io che venivo dalla campagna ero
stupito da questi macchinari così grandi, mi sembravano invenzioni … spaventose!
L’unica cosa che la fabbrica aveva in comune con il ricordo della campagna era
il forte calore del periodo estivo.
Gli stenti erano tanti, ma io
sono ancora qua a raccontartelo con piacere.
…
Mentre il nonno raccontava il suo
lavoro e la vita difficile che ha dovuto affrontare, sono rimasto impressionato
nel vedere il suo viso sempre sereno e avvertendo anche un pizzico di nostalgia.
A quei tempi non avevano neanche il pane, ma avevano l’amore, la fede in Dio e
la fiducia nella Divina Provvidenza che li aiutava a sopravvivere; noi abbiamo
il pane e tanto di più, ma ci manca l’amore e a volte anche la fede in Dio e la
serenità per accorgerci di tutto ciò che abbiamo.
Giorgio Sciamanna
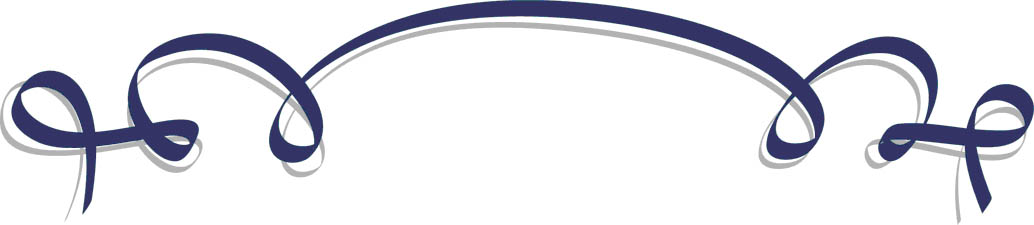
[Ai tempi miei … -
Inserita il 10/11/2012]